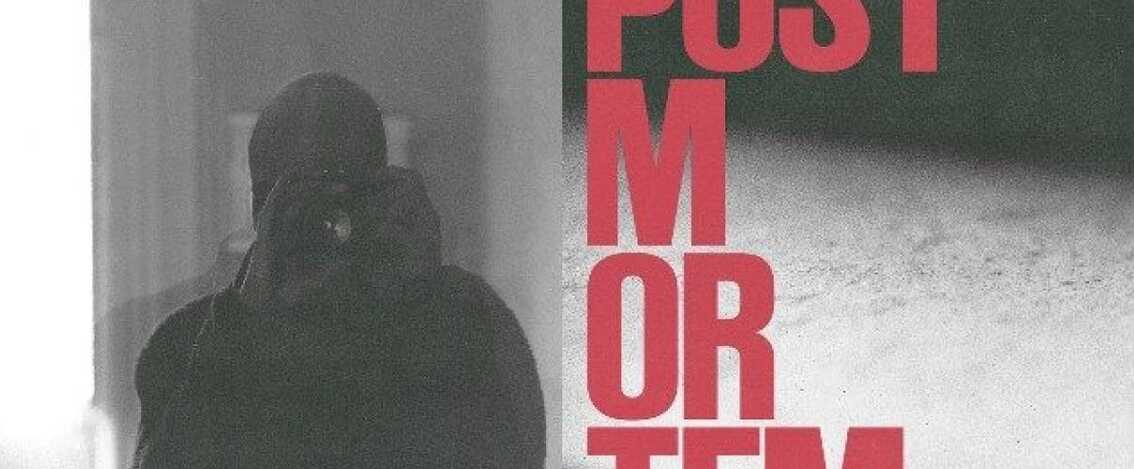
Daniel Ek, CEO e fondatore di Spotify, quindi tecnicamente uno dei principali responsabili della orribile china che la musica contemporanea ha preso, inutile star qui a specificare perché, ha avuto a dichiarare, ormai tempo fa, che gli artisti non dovrebbero più interessarsi agli album, roba d’altri tempi, tirando piuttosto fuori musica con una certa continuità, un singolo al mese, ha ipotizzato. Dal che si evince che per lui la musica è solo una mera faccenda di mercato, chi mai avesse dubitato il contrario o non ha idea di cosa sia la musica o si merita di ascoltare la merda che gira oggi, e che gli artisti, nella sua visione del mercato che in qualche modo ha contribuito a brutalizzare, sono una delle tante realtà coinvolte, sicuramente non la più rilevante. Del resto ha ideato una piattaforma nella quale la qualità di ascolto non è il core business, anzi, non è proprio presa in considerazione tra le opzioni possibili, che mai gli dovrebbe fregare se il singolo che gli artisti dovrebbero a suo dire tirare fuori una volta al mese è arte o robaccia fatta senza cura e ispirazione, tanto per esserci e dar seguito a un flusso?
Preso atto che in molti si stanno adeguando a chi in fondo non ha fatto altro che dire “la palla è mia, detto io le regole”, omologando la propria musica agli standard al ribasso del mercato attuale, muovendosi nella ristretta gabbia che un ascolto posticcio su uno smartphone prevede, andando quindi a inseguire stream spesso fittizi, pochi secondi distratti e via un altro, magari andando a collaborare altrettanto posticciamente con chi al momento ha numeri sufficiente per creare quel flusso, fanbase più fanbase è meglio che one, come direbbe oggi uno Stefano Accorsi facesse ancora spot televisivi. Strana situazione, questa, dove è la modalità di ascolto predominante a dettare la linea artistica del momento, e non viceversa, il tutto mentre è proprio la modalità di ascolto a essere caratterizzante ovviamente della musica di quest’epoca opaca, distratta e frammentaria, triste destino di un secolo, poco meno, nel quale i generi musicali si sono susseguiti in qualche modo interfacciandosi con la cultura e la controcultura, caratterizzando epoche e costumi. Questo lo stato dell’arte oggi.
Bene, anzi male, ma in questo scenario post-apocalittico ecco che c’è chi se ne fotte di tutto e tutti, letteralmente e letterariamente, e decide, dopo aver dato il via a uno vero e proprio involontario movimento, quello prima indicato come indie e poi come itPop, nomenclatura forse più precisa, non fosse altro per le intenzioni di chi vi si stava muovendo, si è apparentemente ritirato a vita privata, mollando il proprio marchio di fabbrica per dedicarsi a qualche produzione, su tutti Coez, Calcutta, Tutti Fenomeni e Laila Al Habash, e qua e là tirare fuori qualche chicca, scrivere canzoni per altri e rarities a nome proprio, quasi sempre fuori da reali logiche di mercato. Parlo, non credo servano i disegnini o le didascalie, di Niccolò Contessa col suo progetto I Cani, artista e realtà che a partire dal 2011, anno di esordio sulla lunga distanza col Il sorprendente album d’esordio de I Cani, in nomen omen, ha segnato realmente una svolta nella storia della musica italiana, creando un punto di contatto tra quello che veniva indicato come alternative/underground e cantautorato, il resto della storia, anche nel suo triste epilogo lo conosciamo già. Una carriera fulminante, pregna di canzoni epocali e generazionali, ditemi voi un altro nome che abbia cantato i Gen Z come lui?, raccolte in realtà in così pochi lavori, dopo quel disco è stata la volta, nel Glamour un paio di anni dopo, e poi Aurora nel 2016, poi l’addio alle scene, sempre mantenendo quella distanza radicale e rigorosa con la comunicazione ufficiale, senza star lì a dare spiegazioni. Un ritiro, possiamo chiamarlo serenamente così, che ha avuto un break giusto per quei quattro brani pubblicati negli anni a suo nome, Nascosto in piena vista, Alla fine del sogno, Un altro Dio e Fiore, e quel I Cani Baustelle del 2023, vai poi a capire come descrivere quel bizzarro Q-Disc uscito in vinile e su bandcamp, apparentemente, la parola apparenza nel caso di Contessa e de I Cani ha un peso specifico altissimo, si pensi al joke messo in scena alla corte di Lundini, sempre per rimanere nel campo del situazionismo puro, un riaffacciarsi sulle scene, senza però che la cosa prendesse di lì a breve una forma intellegibile a noi comuni mortali. Poi oggi, così, all’improvviso, ecco che 42 Records, etichetta discografica indipendente che da sempre pubblica i lavori de I Cani, annuncia il ritorno di Contessa, e stavolta con un intero album dal titolo Post Mortem. Un album che arriva come un fulmine a ciel sereno, e di cui infatti, esattamente come succede coi fulmini rispetto ai tuoni, prima si vede e poi si sente, tutti a gridare al miracolo anche prima del tempo minimo consentito per un ascolto sensato. Ascolto sensato che il vostro affezionatissimo ha provato a fare, saltabeccando di traccia in traccia nei tempi morti tra un colpo di martello pneumatico e l’altro dei muratori che sopra la sua testa, che poi sarebbe la mia testa, parlare in terza persona non mi viene poi così naturale, mi hanno concesso, maledetti lavori di ristrutturazione dei vicini di casa. Un lavoro importante, nei suoni, radicali come sempre, anche loro, tra elettronica e suoni acustici, sempre in bilico su un lo-fi di grande impatto emotivo, oscuro e depressivo, come del resto i testi, impietosi nel descrivere un mondo in fase di stallo, nonostante i movimenti interiori e esteriori siano più vicini a un sisma devastante che a un fotogramma in stand-by, la voce evocativa come poche altre, ieri come oggi. Canzoni che ci inchiodano, a voi stabilire se come una farfalla dentro la cornice di un collezionista o un Cristo su una croce, vittima e carnefice al tempo stesso. Un lavoro di cui non si può e non si deve scrivere subito, se non per sottolinearne la necessità, e l’ovvia e sorprendente capacità di mangiarsi la scena anche solo all’annunciarne l’uscita, come diceva Brecht?, povero il paese che ha bisogno di eroi o quella roba lì. Curioso leggere che i dialoghi russi che si ascoltano a un certo punto sul finale di Felice, brano che cita anche il Gregor Samsa di Metamorfosi di Franz Kafka, vero e propro pozzo di malinconia, siano tratti da Stalker del regista Andreij Tarkovskij, film del 1979 tratto dal libro Pic nic sul ciglio della strada dei fratelli Arkadij e Boris Strugackij, considerato di fantascienza, in realtà decisamente esistenziale, la Zona nella quale i protagonisti si muovono, luogo astratto e psicogeografico, assolutamente riconducibile all’anima, luogo d’indagine di buona parte delle canzoni del nostro, compresa anche la successiva Nella parte del mondo in cui sono nato, spietata e quasi sarcastica lettura della contemporaneità assai più incisiva di tante dissertazioni sociologiche o antropologiche. Ci sarà modo di ascoltare tutte le tredici tracce con la calma necessaria, e di rimpiangere i tanti anni di silenzio che hanno diviso questo lavoro dal precedente Aurora, nove, assai più di svariate ere geologiche, potremmo riassumere. Per oggi godiamoci questo bagno nella disperazione, nella speranza che quella sublimazione che a volte l’arte ci permette, trovi seguito. Avremo probabilmente altri nove anni per ragionarci su.


