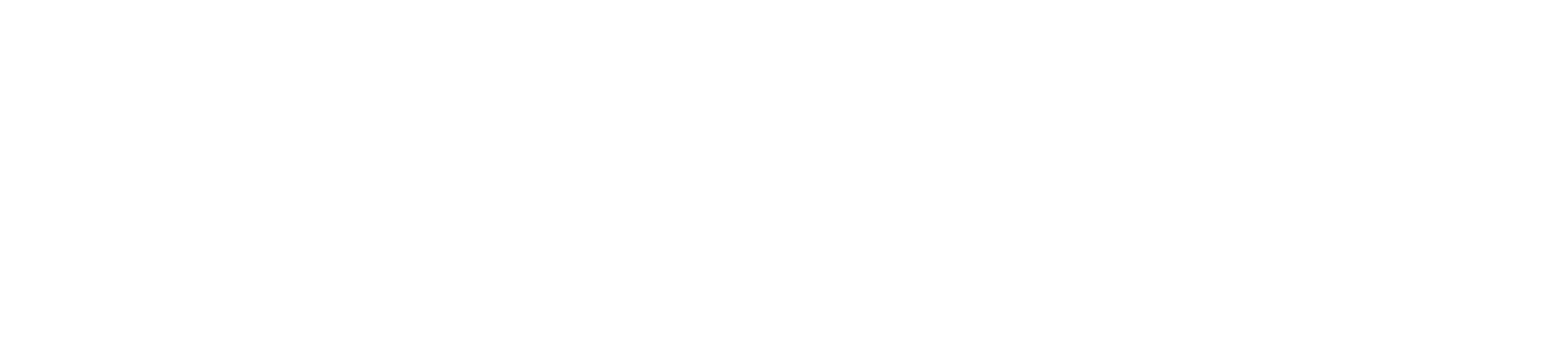L’invidia è un sentimento che non conosco. Questo nonostante di motivi per essere invidioso, in vita, ne ho pure avuti. Penso a quando ero un bambino, prima, e poi un ragazzino cresciuto in un quartiere che non era esattamente quello nel quale la mia famiglia aveva deciso di vivere, andando così a confrontarmi e confrontarci quotidianamente con famiglie e quindi bambini e ragazzini decisamente più agiati di noi e di me. Era successo, è una storia vecchia che ho già raccontato, che nel 1972 nella mia città natale, Ancona, c’era stato un terribile terremoto. Un terremoto uscito dalla memoria collettiva, parlo di nazione, non certo di chi in Ancona ancora vive, perché non ha mietuto vittime, ma che ha distrutto parte della città, e tenuto quindi la cittadinanza in scacco per molti mesi. Avendo la mia famiglia perso la casa nella quale abitava, nel centro storico, ai tempi zona popolare oggi ricercatissima, il Comune ci aveva messo a disposizione una delle tante abitazioni sfitte che aveva chiesto in prestito ai proprietari, proprio per andare incontro ai tanti sfollati. A noi era capitata la casa di colui che nel mentre era divenuto il Prefetto di Macerata. Ora, capite come un impiegato dell’azienda tranviaria, mio padre, e una casalinga, mia madre, non fossero esattamente in linea col prefetto di una città, parlo di status, e non a caso nel nostro palazzo abitavano dirigenti della Regione, professori universitari e altri professionisti di un certo livello. Quindi il me bambino e il me ragazzino si sono spesso trovati a vedere i propri amici e compagni di scuola avere e fare cose che non erano loro consentiti, ditemi voi se vi è mai capitato di leggere di qualcuno che parla di se stesso usando la terza persona plurale, il mago Othelma escluso, una certa invidia mi sarebbe anche stata consentita. Invece questa faccenda dell’avere e fare meno degli altri, nonostante gli sforzi titanici dei miei, mi è servita da una parte per sviluppare la fantasia, con la quale oggi lavoro, dall’altra nel crescere con un profondo senso di avversione nei confronti del capitalismo e delle sue derive, fatto del quale in fondo non posso che essere grato a certi Big Jim che mi sono stati negati, o al motorino, ma arrivato compiuti i quattordici anni.
Tornando all’invidia, quindi, non è parte del mio armamentario, se non in una sua forma benevola, ne parlavo qui anche giorni fa, che mi vede invidiare il talento di chi mi è in qualche modo collega ma ritengo più geniale di me, pochi nomi, quasi mai italiani (in quel caso parlavo di Fossati, qui https://361magazine.com/ivano-fossati-e-come-le-canzoni-ci-aiutano-a-vivere-ma-non-a-non-morire/). Quando mi capita di leggere David Foster Wallace, per dire, provo invidia per il suo stile e per quel che dice. Idem per Douglas Coupland, William T. Vollmann, Bret Easton Ellis, Rick Moody, Hunter Thompson. Invidio anche Alan Moore, che però è più un autore di fumetti che di libri, quindi come nel caso di Fossati non è esattamente un mio collega, se non di sguincio, e pochi altri. Ecco, tra questi pochi altri ci sono due donne, Shilley Jackson e colei che in qualche modo potrebbe essere stata la sua sorella maggiore, Kathy Acker. La prima è stato un vero e proprio amore intellettuale, per me. L’ho conosciuta casualmente, parlo delle sue opere, mentre stavo facendo delle mie ricerche su come si potesse lavorare letterariamente e rappresentativamente sul corpo delle donne. Anche questa è storia vecchia, della quale ho scritto. In pratica ormai quasi quindici anni fa mia figlia grande, quella Lucia che leggete sempre da queste parti, ha iniziato a passare dallo stato di bambina a quella di adolescente. Da scrittore, ma soprattutto da padre di una bambina che stava diventando adolescente, mi sono sentito spiazzato, incapace di raccontarle con le giuste parole cosa le stava capitando e a cosa sarebbe andato incontro. Ho così deciso di chiedere a una serie di cantautrici indipendenti con le quali ero entrato in contatto per il mio lavoro di critico di venirmi in aiuto. Questa l’idea, ognuna di loro avrebbe dovuto scegliere una parte del corpo sulla quale scrivere una canzone, così da costruire una sorta di anatomia femminile. Parte del corpo che sarebbe servita, più che a raccontare i cambiamenti fisici ai quali stava andando incontro, per raccontare cosa volesse dire essere donna qui e oggi, nel qui e oggi di allora, parliamo del 2010, 2011. Gli anni delle Olgettine, delle cene eleganti, del Se non ora quando, del documentario della Zanardo Il corpo delle donne, per capirsi. A fianco alle canzoni, ventitré, una delle quali scritta da me con Andrea Mirò, la cantautrice più nota di quel gruppo, e da lei cantata, lì a raccontare tutto il progetto, la fotografa Zoe Vincenti, ex cantante della band Vertigini, avrebbe ideato ventitré fotografie, atte a rappresentare ugualmente le parti del corpo cantate. Il tutto sarebbe poi uscito in un cofanetto comprendente l’album e un libro con le foto e un mio testo. Titolo: Anatomia Femminile. Ecco, Anatomia Femminile si ispirava, dichiaratamente, a un progetto di Shelley Jackson, presente nelle librerie italiane col solo titolo La melancolia del corpo, Patchwork Girl. Il titolo di quel progetto era un chiaro omaggio a Frankstein, il Patchwork man per antonomasia, e il progetto consisteva in un ipertesto online che partiva da un disegno fatto dalla stessa Jackson di una donna nuda dove, cliccando nelle singole parti, si aprivano testi poetici e narrativi. Lei, Shelley Jackson, avevo letto, aveva dato vita a altri progetti geniali, come quello chiamato Skin, che vedeva un racconto di oltre mille parole tatuato addosso a altrettante persone, una per ogni volontario, così da formare un testo vivente e mutevole. Mutevole perché ogni singola parola era legata a chi ce l’aveva addosso, se qualcuno avesse deciso di rimuovere il tatuaggio il racconto sarebbe cambiato, così come sarebbe cambiato con la morte dei singoli soggetti coinvolti. Capite bene la genialità del tutto. Da Patchwork Girl è nata l’idea per Anatomia Femminile, il progetto uscito il 23 settembre del 2011, e da quel progetto sono nate tante tantissime iniziative e progetti sempre sotto quel titolo, dal Festivalino di Anatomia Femminile a Cantami Godiva a Venere senza pelliccia, dischi, eventi, libri, Ted-X, monologhi teatrali, tutti incentrati sul cantautorato femminile, sulla rappresentazione del corpo della donna e relativi stereotipi nelle canzoni, insomma, da quel momento parte della mia vita professionale ha cominciato a occuparsi di tutto questo.
Shelley Jackson, dicevo, si è sempre considerata un po’ una sorella minore di Kathy Acker, scrittrice, performer e tante altre cose nata a New York nel 1947 e morta a Tijuana cinquant’anni dopo. Una scrittrice che è quasi impossibile raccontare in poche righe, oltre che ingeneroso, a lungo a flirtare con la scena No Wave della sua città natale, ha praticato una scrittura che è di volta in volta stata identificata come avant-pop, postmoderna, cyberpunk proprio per quel suo prendere i generi e farli a pezzi, spesso andando a inserire nei suoi testi testi scritti da altri, a volte riscrivendoli come fosser cover di racconti o addirittura di romanzi, sempre giocando con la lingua e con le immagini, lavorando di cut up, di citazionismo, di destrutturazione. Una sua foto in topless, dove al posto dei seni si possono vedere le due cicatrici frutto di operazioni di mastectomia, Kathy è morta proprio in seguito a un tumore al seno, è una delle sue immagini più note, insieme a quelle col giubbotto di pelle a far da pendent ai suoi capelli corti, biondo platino, o quelle sempre in topless, pre mastectomia, mentre è in sella a una Harley Davidson.
Ora, uno potrebbe dire che aver citato tra gli artisti che invidio, bonariamente, tre autori morti, David Foster Wallace, Hunter Thompson e Kathy Acker, di cui due suicidi, i primi due, non depone troppo a mio favore, ma credendo profondamente che l’arte è eterna, a differenza della carne umana, credo che il senso del mio discorso sia comprensibile anche ai meno sensibili.
L’ho presa un po’ lunga, lo so, ma credo fosse necessario farlo, e so che mi avete seguito comunque fin qui.
Tornando a Kathy Acker, è su di lei che vorrei concentraste l’attenzione, figuratevi la mia sorpresa quando, leggendo della notizia della riedizione del bellissimo album d’esordio di Dada Sutra, Questo nostro amore mortale, ora Questo nostro amore mortale PIÙ, nella cui tracklist compare una canzone che porta per titolo esattamente: For Kathy Acker. Io Dada Sutra l’ho conosciuta durante il Covid, quando era possibile tornare a incontrarsi ma non era ancora possibile riprendere tutte le attività normali. Aveva tirato fuori un suo EP e cominciava a fare promozione, così l’avevo intervistata. Faceva una musica ostica, volutamente disturbante, molto personale, e io adoro chi si prende la briga di essere scomodo e disturbante, confesso di passare parte del mio tempo a fare esattamente questo. Non ci siamo persi di vista nel tempo, ha preso parte anche lei al Festivalino di Anatomia Femminile, e quando è uscito il suo primo album è stata mia premura scriverne, oltre che invitarla alla rassegna Temporary Music, che ho curato insieme al cantautore Santoianni, in una serata che la vedeva protagonista insieme a quella Valentina Parisse di cui ho parlato qui https://361magazine.com/valentina-parisse-lamica-geniale/. Io trovo che Dada Sutra, che in realtà si chiama Caterina Dolci, e che oltre che questo suo progetto solista è anche la bassista delle Bambole di Pezza, incidentalmente stasera protagoniste di un sold out ai Magazzini Generali, sia una delle cantautrici più interessanti attualmente in circolazione in Italia. Dovessi fare un elenco, e grazie a Dio non devo, la includerei indubbiamente anche in una lista ristretta, di quelle che in una discoteca avrebbero accesso all’area Vip o al privè, in buona compagnia, che so?, con Kayla Trillgore, Yoniro, Marta Tenaglia, Mille, Lamante, Giulia Mei, Elasi, Dadà, con una parte di questi nomi anche accomunata da una ricerca di un immaginario che tracima dalle canzoni per dar vita a un vero e proprio mondo alternativo, distopico, vagamente cyberpunk, appunto come quelli immaginati da Shelley Jackson e ancor più da Kathy Acker. A metà strada tra un Blade Runner e una Berlino vagamente postatomica, infatti, Dada Sutra, accompagnata dal suo basso e dalle macchine ha costruito una tracklist profonda e originale. Parlando di lei, in precedenza, ho usato, oltre all’aggettivo disturbante, che ripeto è assolutamente coerente con la sua poetica, parole come inquietudine, industrial, noise, cantautorato, evocando immagini come un peep show di Amsterdam, ma anche un giro nelle metropolitane berlinesi di notte, un corpo cangiante, un po’ versione femminile del Tetsuo di Shin’ya Tsukamoto o Alexia, la protagonista di Titane di Julie Ducoumau, un po’ la protagonista di Sangue e viscere al liceo, dalle cui pagine è per altro stata estrapolata la frase che è il mantra del brano che ha per titolo il nome della scrittrice americana, anche se pure L’impero dei non sensi ci ha regalato immagini e pagine imperdibili. Questo nostro amore mortale PIÙ è assolutamente da ascoltare, come è da ascoltare il live che intorno a questo album ruota. Dada Sutra è un nome centrale, per il cantautorato femminile del 2025, mi sembra evidente, con alcuni dei nomi qui su scritti, e una delle più ardite nell’affrontare la forma canzone e spingerla in avanti, in territori ostili, campi minati, veri e propri bordelli. Sempre in quei miei precedenti scritti, nel quali mi ero occupato di lei, avevo mosso le mie parole a partire da un suo post su Instagram, nel quale parlando dell’estate appena trascorsa, era quella del 2024, citava bagni in laghi ghiacciati e naturismo, mostrando una foto del suo culo, seppur in lontananza. Il corpo è presente nelle sue canzoni, come negli scritti proprio di Kathy Acker, lo è per il modo nel quale percuote le corde del basso, usa una voce che si fa metallica, algida, ma sensuale, creando appunto quello stato di disagio che si può provare entrando in una sauna dei paesi nordici, nei quali ci è imposto di lasciare ogni indumento negli spogliatoi, il sudore e la naturalezza uniche difese del nostro eventuale pudore. Un disagio che si fa fascinazione, il rosso stinto della copertina, o quello acceso delle foto promozionali, che transmuta nell’argento del metallo, un lieve strato di vapore a rendere il tutto sfocato. Se mai esistesse la possibilità, oggi, di portare su un palco l’idea che era alla base di Anatomia Femminile, per dire, in una versione 2.0, è a Dada Sutra che penserei, senza esitazione. Anzi, ci sto proprio pensando.
Se è tutto questo che state cercando Questo nostro amore mortale PIÙ è quello che fa per voi. Se non lo state cercando, male, andate e non peccate più, fate sempre in tempo a cambiare idea.