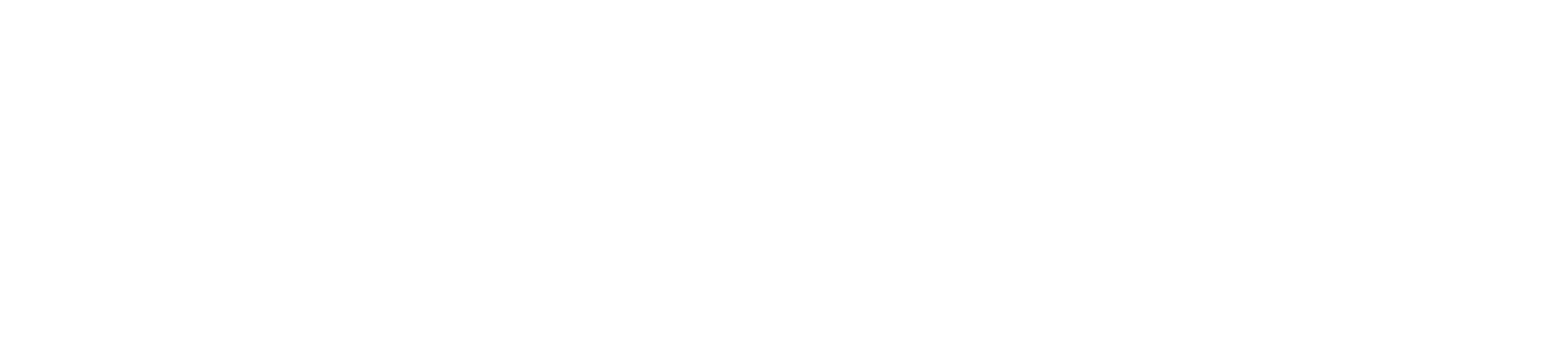Il 15 agosto del 1971 il presidente degli Stati Uniti d’America, Richard Nixon, dichiarò in televisione che cadeva il Gold Exchange Standard, cioè di colpo sganciava la possibilità di uno stato di emettere moneta dal proprio possedimento aureo. Una data importante per chi studia economia, certamente anche storia, ma che in qualche modo è fondamentale anche per chi si limita a vivere nel pianeta Terra, perché è identificabile come il momento preciso in cui l’iperreale si è definitivamente staccato dal reale, compiendo lo scatto in avanti per sostituirlo. In realtà già nel dopoguerra questa sostituzione era cominciata, o almeno era cominciata la teorizzazione di questa sostituzione. Il capitalismo, questo sosteneva già in quegli anni Settanta Jean Braudillard parlando di realtà e di simulacri, aveva cominciato una sorta di “messa in valore” del mondo, arrivando poi appunto al distacco definitivo del mercato dalla domanda sociale di beni, sostituita dal mercato stesso, il capitalismo finanziario speculativo come evoluzione/involuzione del tutto. Il simulacro ha sostituito da quel momento il reale, arrivando all’assurdo, Braudillard lo teorizzava allora, la sua morte nel 2007, anno di approdo nel mondo del primo social network globale, Facebook, non è da leggere come una semplice coincidenza, che qualcosa diventa vero quando viene certificata dal fatto di essere stata detta in televisione, la copia del reale più vera del reale stesso. La copia iperreale sostituisce definitivamente la realtà, leggi alla voce persuasione di massa (a questo punto si potrebbe parlare anche dell’aura di Walter Benjiamin, e della perdita di efficacia dovuta alla riproducibilità dell’arte, ma andremmo allargando decisamente troppi il discorso). Il trionfo delle merci, volendo usare definizioni canonizzate dal marxismo, ha portato non alla creazione di modelli falsi, l’iperreale non è falsità contrapposta a realtà, quanto piuttosto a qualcosa di non vero ma non necessariamente falso. La comunicazione di massa, questo intuì Braudillard, ha quindi assunto il compito di dirci cosa fosse o non fosse vero, in una incredibile trascendenza da ciò che è, sostituzione forzata e forzosa di quella un tempo affidata alla teologia. Spingendo fermamente in un assai vintage tasto Forward, oggi tutto questo è divenuto ovviamente ben altro, con l’iperconnettività che l’arrivo di internet ha prima permesso e poi imposto, rendendo ormai la reale realtà la meno attraente e quindi meno credibili tra le realtà possibili. Le realtà aumentate, quelle che partono dal basso, teoricamente veicolate da noi, e quelle che ci arrivano dall’alto, imposte come modelli, hanno portato a un definitivo dominio del simulacro sul reale, direbbe Braudillard e noi con lui, il virtuale, così ci siamo abituati a chiamarlo, dove virtuale e virtuoso potrebbero anche finire per confondersi, assai più accattivante del non virtuale, in esso incluso come una delle tante sfumature, certo non la centrale. Se un tempo i nostri genitori potevano dire che qualcosa era vero perché era stato detto al telegiornale, oggi i nostri figli li imitano accelerando verso un “è vero, l’ho sentito su Tik Tok”. Il tutto da non leggere come stigmatizzazione dei social, bene inteso, quanto piuttosto come constatazione amichevole di un avvenuta modifica di percezione di quel che ci succede intorno, tutti artefici, consapevolmente o meno, di un’operazione o opera di autofiction quotidiana. Autofiction che nel mentre è divenuta anche genere letterario primario, arte, quotidiano e media/social media tutti a guardare nella stessa direzione, lavorando a un modello unico di decifrazione del mondo: un simulacro estetizzato.
Curioso che in questo la lettura più diffusa, e quindi in questa logica data per vera, sia che in un’epoca come questa, dove tutti hanno la parola e un palcoscenico, il solo modo per rendere autorevole il punto di vista di un autore sia appunto quello di sostituirlo con un avatar, un personaggio che renda “credibile” quel che dice, avatar la cui credibilità è data proprio dalla sua presenza.
Provo a spiegarlo diversamente.
C’è questo cortometraggio di qualche anno fa che si intitola I’M Bob. I’M Bob, come Bob Geldof. È diretto da Donald Rice, che non ho idea chi sia, e ha come interprete principale, toh, Bob Geldof, nei panni di Bob Geldof. Non ricordo chi me lo ha segnalato, è un cortometraggio del 2007, ma ogni tanto mi capita di tornare a vederlo, perché è geniale. Inizia con Bob Geldof seduto sui sedili posteriori di una limousine bianca, fuori è notte. Arriva una telefonata che gli propone qualcosa, noi sentiamo solo la sua voce, quindi possiamo capire di che si tratta dalle sue risposte, e quindi lo sentiamo rifiutare non si sa bene che evento benefico per un orfanotrofio in Romania, perché, parole sue lui si occupa solo di Africa. Un Bob Geldof cinico, quindi, che a un certo punto si trova costretto a una sosta inaspettata e imprevista in mezzo al nulla, perché l’autista deve andare a fare pipì. A prima vista dobbiamo trovarci in mezzo alla campagna inglese, roba da romanzo di Jane Austen, o da Un lupo mannaro americano in Inghilterra di John Landis.
C’è un pub, ovviamente, l’autista è lì che va a pisciare. Poco prima, chiedendo imbarazzato se poteva fermarsi si è dovuto interfacciare con un Bob Geldof ancora più scazzato di quello sentito durante la telefonata, che ha chiuso la conversazione tirando su il divisorio nero tra lui e l’autista. L’autista scende. Dopo un po’ Bob scende per pisciare, tanto la musica che proviene dal pub gli impedisce di dormire. A differenza dell’autista, lui è Bob Geldof, decide di farla all’aria aperta, tanto è notte e in giro non si vede nessuno. Non si vede nessuno e nessuno vede lui, nel buio, neanche l’autista che, di ritorno dal pub, sale in macchina e riparte. Bob se ne accorge, si tira su la zip, grida, si sbraccia, ma niente, ormai la limousine bianca si è allontanata. Aver tirato su il divisorio nero e aver detto che voleva dormire non è certo di aiuto, in occasioni come questa. Ottimo incipit, converrete, che ci mostra subito, in partenza, un grande Bob Geldof, sì a interpretare se stesso, ma con una forte dose di autoironia. Da questo momento parte la trama vera e propria, dove Bob Geldof, il Bob Geldof della finzione interpretato dal vero Bob Geldof, accortosi di non avere con sé il telefonino, lasciato in auto mentre andava a pisciare, non ha altra possibilità che entrare nel pub e chiedere aiuto, lui che si occupa solo di Africa. Bob entra nel pub proprio mentre un anziano signore sta dicendo a una donna con una buffa acconciatura cotonata che è l’ultima volta che intende fare qualcosa del genere, invocando per la prossima volta Keith Chegwin, presentatore tv di non troppa chiara fama. Bob entra infilandosi gli occhiali da sole, per non essere riconosciuto, subito fermato da un tizio che gli chiede una moneta, moneta che ovviamente lui non ha. Si avvicina all’anziano signore e alla donna e chiede loro dove sia questo pub, sentendosi rispondere Long Marston, a sessanta miglia da Kirkby, nel Lanchashire, su al nord, non esattamente l’ombelico del mondo, immagino. Bob chiede se ci sia un telefono, sentendosi rispondere che è solo per i clienti del motel, poi chiede se c’è una stazione di polizia, ma il solo poliziotto è lì, e non intende essere disturbato. A quel punto spiega che gli è successo, dicendo che sta andando a fare un concerto per i poveri su al nord, altro tocco di cinismo autoironico, ma nessuno dei due suoi interlocutori sembra credergli. Quando poi dice di essere Bob Geldof ottiene in risposta una squassante risata dalla donna, che gli fa i complimenti, non prima di avergli chiesto se smetterà mai di chiedere fottuti soldi alla gente (lui risponde ovviamente “credo di no”), salvo poi dargli una moneta per andare a telefonare, il telefono è ovviamente vicino al bagno delle signore. Mentre si sta incamminando la donna, nei fatti la cameriera del pub, gli dice “Se qualcuno ti dovesse fermare digli che ti ha dato il permesso Patsy Cline”, con tanto di occhietto ammiccante. Bob va al telefono e inizia a lasciare un messaggio pieno di insulti dentro una segreteria telefonica, spiegando la situazione, anche se non riesce a finire le indicazioni perché al telefono di fianco al suo vede esserci un tizio uguale identico a Saddam Hussein. Bob esce dalla zona bagni, entra nel locale vero e proprio e ora si capisce bene cosa sta succedendo, infatti c’è un tizio sul palco che sta dicendo che George Michael è in ritardo ma in compenso c’è Michael Jackson, questo mentre Elton John passa a due metri scarsi da Bob. Siamo nel bel mezzo di un concorso per sosia. Gli si affianca una cameriera che fa Marylin Monroe e gli chiede, chiamandolo Bob, se vuole da bere, ma lui rifiuta, sentendosi quindi dire “sei un disastro, Bob, un irlandese che rifiuta di bere”, e da quel momento comincia un secondo racconto, ancora più esilarante di quanto non sia stato fin qui, perché il solo modo che Bob ha di fare qualche soldo per potersene andare di lì è vincere il primo premio del concorso. A fargli capire che deve partecipare il sosia del papa, in realtà l’unico taxista disponibile in questa anomala serata, taxista che però gli chiede quattrocentocinquanta sterline per portarlo su fino a Glasgow. La faccio breve, perché questo non è un bigino di questo cortometraggio, che vale comunque la pena di essere visto, ripeto, non posso tacervi che dovrà vedersela con un altro pretendente sosia di Bob Geldof, sulle note della più che scontata I Don’t Like Mondays dei Boomtown Rats, davanti a un pubblico di sosia di Spok di Star Trek, di Regine Vittoria, di Sherlock Holmes e Elvis. Il finale, quindi, dovete andarvelo a scoprire da soli.
Il motivo per cui sto parlando da anche troppe parole, quasi mille su milleottocento circa, di I’M Bob, cortometraggio del 2007 di Donald Rice, è che l’idea di essere riconosciuti come meno se stessi di se stessi mi sembra davvero essenziale oggi, nell’epoca degli avatar, del mondo dell’apparenza sui social, volendo anche del mondo nel quale non decidiamo di apparire diversamente da come siamo realmente, sui social. I’M Bob ci dice, chiaramente, come a volte gli altri siano in grado di cogliere certi nostri vezzi che a noi sfuggono, al punto da faticare a indicarli, nel caso ci venga richiesto di farlo, come in questo caso specifico, e quindi ci dovrebbe indurre a capire come la nostra identità sia indubbiamente un valore assoluto, ma da trattare come qualcosa di modificabile, altro da noi, al pari della nostra poetica, se siamo tra quanti hanno una poetica. Farsi simulacro del nostro stesso simulacro come sola strada percorribile, sia mai che si completi il giro lasciando che per qualche istante, come la storiella dell’orologio rotta insegna, si torni a essere reali.